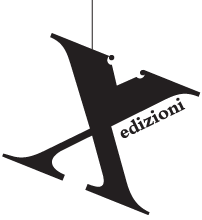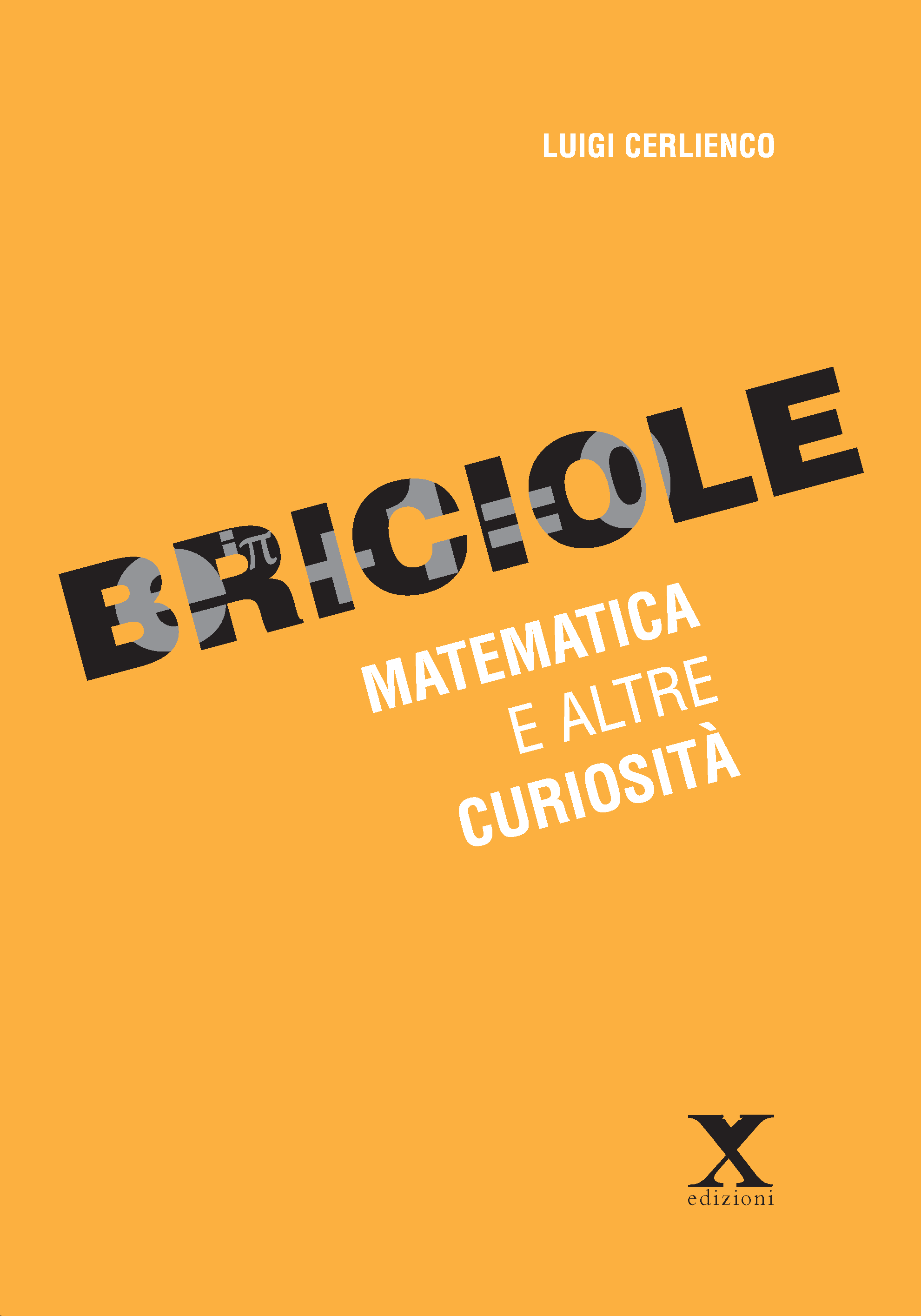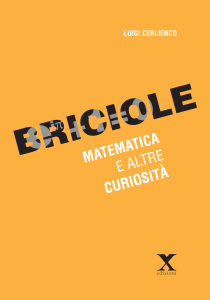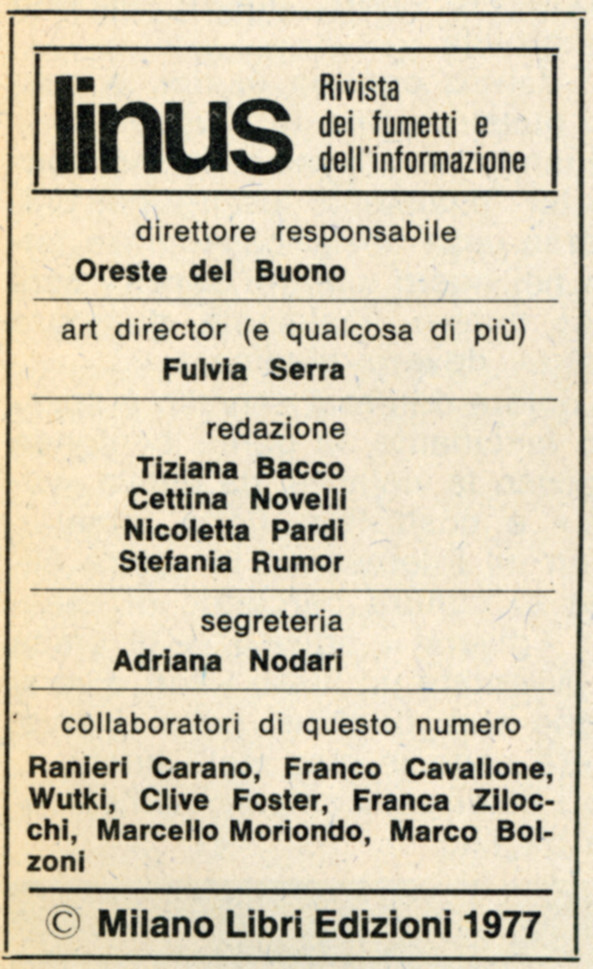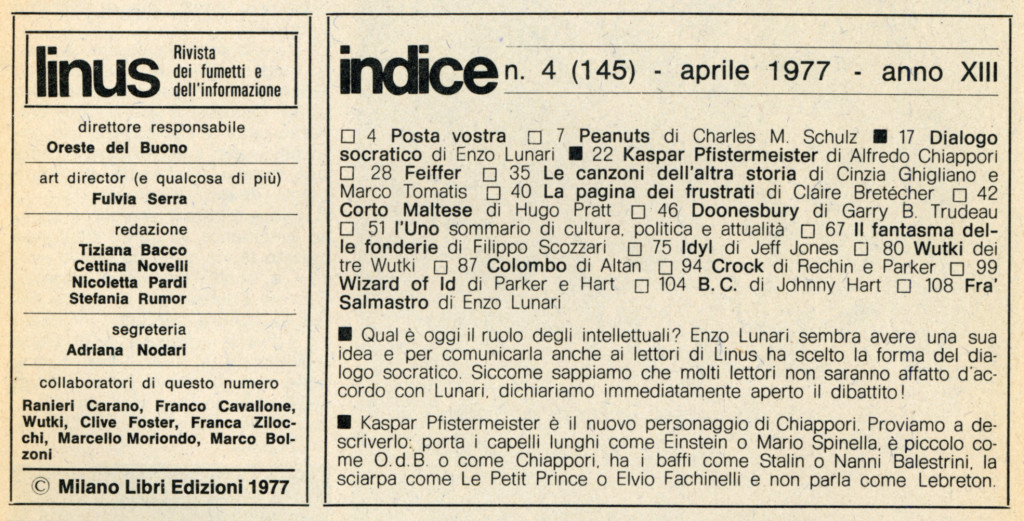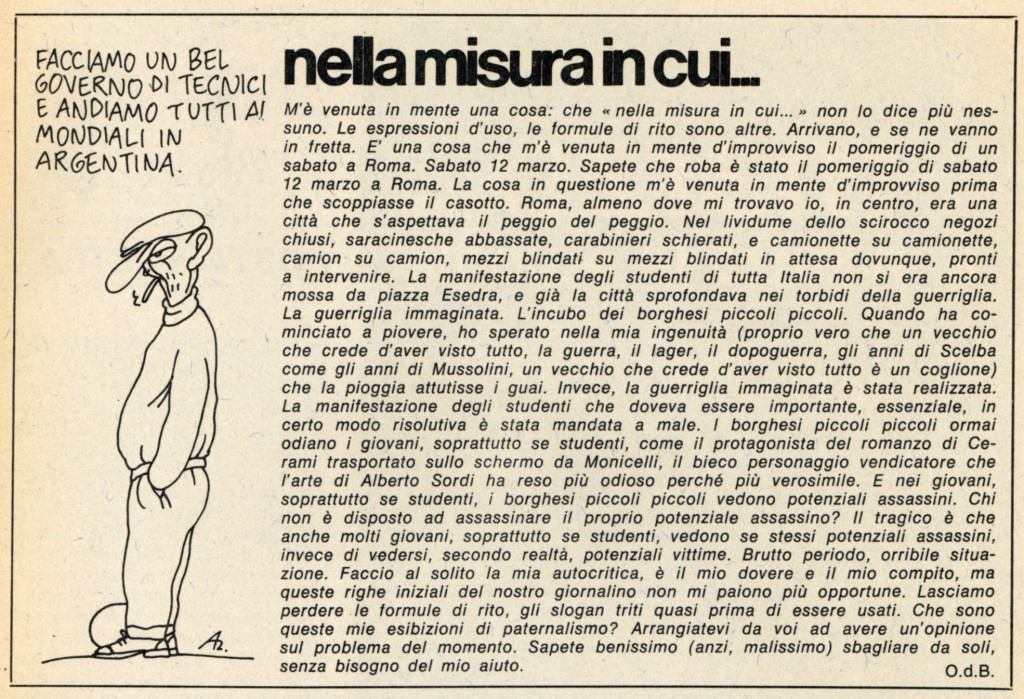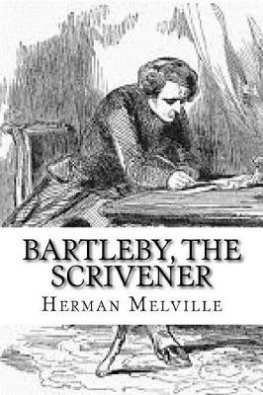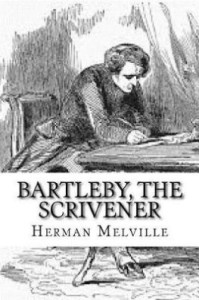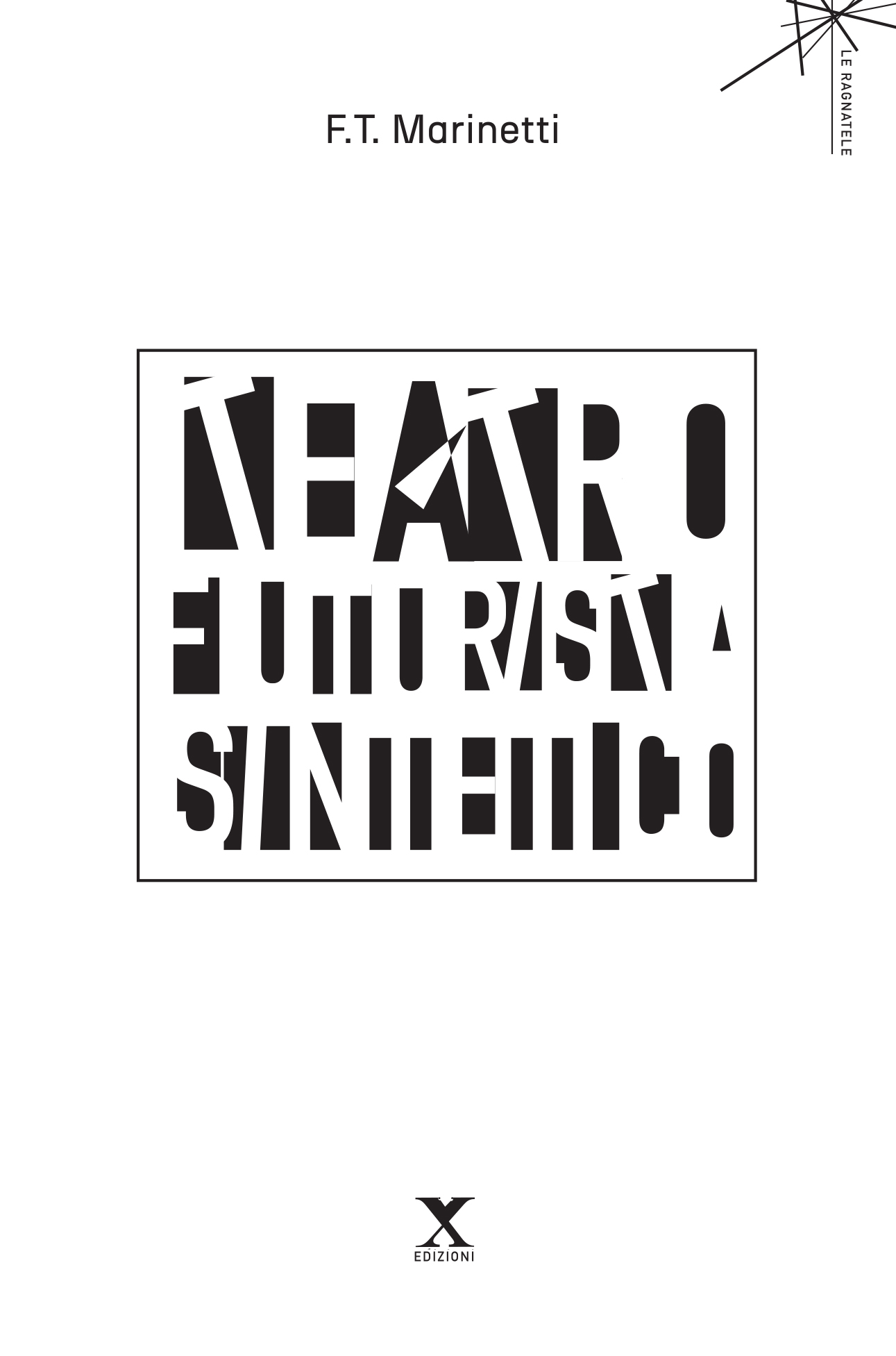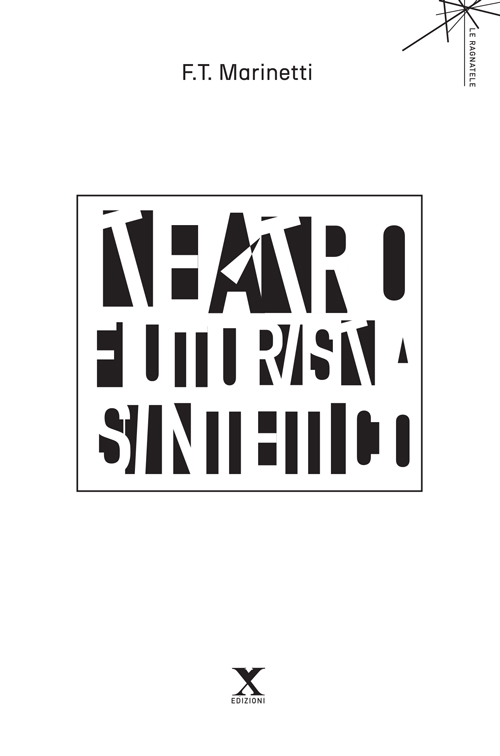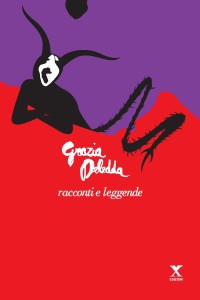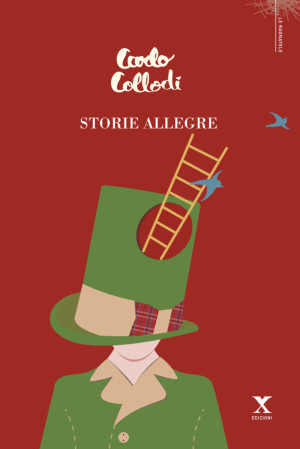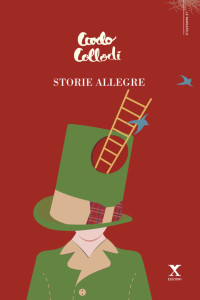Iniziava alcune settimane prima, con un mazzo di cartoncini di auguri pasquali. Una sera babbo diceva: dobbiamo mandare gli auguri di pasqua. state qui così li firmate anche voi. I cartoncini erano bellissimi, con morbidi pulcini gialli, coniglietti, agnelli bianchissimi, cestini di uova, nastri svolazzanti, calessi tirati da piccoli cavalli sorridenti, bambini e bambine vestiti con colori vivaci e primaverili. Babbo aveva una minuscola agenda con tutti gli indirizzi: zio Giorgio in Venezuela, zia Maria a Roma, zio Elio a Velletri e così via. Nomi mitici e misteriosi per noi che non li conoscevamo. Ma c’erano anche gli ex vicini di casa che invece conoscevamo bene e ci ricordavano i tempi di quei luoghi. Dunque, vediamo… prendeva un biglietto, lo apriva, questo va bene per zia Maria, e mentre cercava la frase da scrivere, la penna cominciava a muoversi, con gli stessi movimenti della scrittura ma senza alcun contatto, come prendere una rincorsa. E quando cominciava a scrivere veniva fuori una frase bellissima, originale, perfettamente adatta al destinatario. Babbo era bravissimo a pensare e scrivere frasi di tutti i generi, auguri, inviti, condoglianze, con una calligrafia elegante, inclinata, perfettamente allineata in righe immaginarie che contenevano le minuscole e le maiuscole tutte alla stessa altezza, come nei quaderni a righe di seconda. In fondo c’era la firma con svolazzo finale, che ho tentato inutilmente di imitare in molte occasioni. Ora il nostro compito era quello di rovinare quel capolavoro, aggiungendo i nostri nomi. Dai, bambini, firmate anche voi. Tu, qui! ma non così piccolo! scrivi bene! possibile che non sappia neppure scrivere il tuo nome!? erano brevi momenti di ansia da prestazioni, ma poi alla fine l’atmosfera era bella, e quel rito segnava l’inizio dell’attesa della Pasqua.
In realtà, mamma aveva già lavorato molto per la Pasqua nelle settimane precedenti, cucendo o comprando gli abiti nuovi per le bambine, gli scamiciati da abbinare con camicetta bianca con i pizzi, calze bianche lunghe al polpaccio, un po’ traforate, e scarpette primaverili, e andando a comprare qualcosa di nuovo anche per i maschietti e le ragazze più grandi, qualcosa da indossare proprio nel giorno di Pasqua, insieme a un paio di scarpe nuove ciascuno. Perché a Pasqua tutto deve essere nuovo, pulito, perfetto. E naturalmente c’era il barbiere per noi maschietti, e qualche taglio casalingo per i capelli delle femminucce.
La domenica delle Palme aveva il suo bel fascino, era la porta che introduceva a quella strana settimana di contrizione, dolore e tripudio, come la porta di Gerusalemme che fu attraversata tanti secoli fa a dorso di un asinello, in un trionfo di sole, folla, palme intrecciate e ramoscelli d’ulivo. Ci faceva capire che c’eravamo, ormai, quasi.
Anche a scuola c’era una fase preparatoria. Si parlava dei tradimenti, dei processi sommari, delle vicende dolorose della Passione e del tripudio della Resurrezione, come se fossero cose reali, storia. D’altra parte allora c’era ancora una religione di Stato, ed era quella. Si studiavano poesie da recitare poi a casa, si facevano disegni colorati con tanto giallo, arancione e celeste. La Santa Pasqua era veramente sentita da tutti. E la primavera si faceva vedere fuori dalle grigie finestre. Fino al brevis lectio del mercoledì, inizio ufficiale di quelle brevissime vacanze.
Partiva il grosso delle attività preparatorie. Tornando da scuola si trovava la casa stravolta dal turbinio delle pulizie di Pasqua (che allora si facevano veramente) e che coinvolgevano tutti. Io mi trovavo spesso a dover lucidare le maniglie d’ottone col sidol, o a dare una miscela di olio e aceto alle sedie del tinello (il “pronto” ancora non c’era), o a pulire sopra gli armadi, dato che ero ancora piccolo. Mi issavano su e provvedevo a raccogliere tutta la polvere con un panno umido. Si formavano degli strani gnocchi nerastri, ed era divertente.
Prima che arrivasse la sera di quel primo giorno di festa la casa era pulita, profumata, incerata e lucidata, e le nostre coscienze erano pulitissime, perché se non avevamo neppure aperto la cartella di scuola avevamo un ottimo motivo. Intanto, forse proprio quel giorno, forse il giorno dopo babbo portava la colomba e le uova di pasqua. Sette uova: uno per ciascuno dei figli e uno più grande e pesante per mamma. Tutte fruscianti e crocchianti col loro rivestimento di cellofan e la stagnola sotto. Ognuno aveva il suo, sapeva qual’era, ma non poteva toccarlo. Lo guardava, allineato con gli altri sul buffet della camera da pranzo, insieme con la dolce colomba. Di nascosto lo agitavo per sentire il peso della sorpresa, fosse magari una macchinetta metallica, con le ruote molleggiate, o un’armonica a bocca, chissà.
Il culmine dei preparativi della Pasqua coincideva con la decorazione delle uova sode. Questo ricordo mi ricorda che allora le uova erano bianche, non marroni come oggi. Era bello decorare le uova bianche. Alcune venivano messe a bollire direttamente con qualche colorante, per esempio spinaci, barbabietola, zafferano. Erano belle già così, verdine, gialle, rosa, tutte in un cestino. Ma diventavano bellissime con occhi e becco, code e aluccie di carta, orecchie e coda da coniglio, sombrero e baffoni messicani e così via. Quelle uova stavano lì, a decorare il centrotavola, per i giorni precedenti, e poi per tutto il giorno di Pasqua. Erano da mangiare il giorno di pasquetta, magari in gita.
E poi c’era il giro delle sette chiese, che potevano essere anche cinque o tre, un pomeriggio con mamma, e nell’aria c’era sempre attesa, con i paramenti abbrunati ma con la consapevolezza dell’imminente trionfo. E spesso il venerdì santo il tempo era grigio e mi pareva giusto che dovesse esserlo (almeno a questo doveva pensarci Dio), e la radio non trasmetteva musica leggera e canzonette, ma solo musica classica per favorire la meditazione.
Il sabato era dedicato ai preparativi per il pranzo del giorno dopo, che doveva essere memorabile. Il menù era ricchissimo: ravioli di ricotta, agnello arrosto o in tegame o entrambi, patatine novelle rosolate intere, frittate di favette, di piselli, di asparagi; formaggi, frutta, e poi infine i dolci, il gateau di mandorle, le ciambelle. E infine ci sarebbe stata la colomba e si sarebbero finalmente aperte le uova, mangiato un pezzo di cioccolato, giocato con la sorpresa. Tutto bello nell’aspettativa, ed era bello collaborare, sbucciando piselli e favette, sgusciando mandorle, girando la manovella della macchina per la pasta. E la sera c’era il bagno per tutti, con lo sciampo che bruciava gli occhi ma mamma ci diceva di non piangere, che ci faceva venire gli occhi azzurri. Anche babbo faceva il suo bagno e si preparava, in modo che si andasse a letto tutti puliti e pronti per il giorno dopo. Prima di coricarci noi bambini facevamo un’ultima cosa, “segreta”. Preparavamo la letterina di auguri e buone intenzioni da mettere sotto il tovagliolo dei genitori per il pranzo pasquale. “Cari babbo e mamma, nell’occasione della Santa Pasqua…”, con le cornicette e qualche decorazione più o meno riuscita. Infine si andava a letto, con lo spirito più pasquale del mondo.
”Oggi è Pasqua” è il primo pensiero del mattino, al risveglio. Giornata speciale fin dalla colazione, con un pane dolce con le uova cotte intere dentro, e con la cioccolata al posto del caffellatte. E poi ci sono tutti i riti programmati: la vestizione e la sfilata davanti a babbo, che si goda almeno per un minuto i figli puliti, ben vestiti e con i capelli bagnati per far stare a posto la pettinatura. E poi la messa speciale cantata e suonata (solo noi bambini: babbo è anticlericale e mamma “prega per conto suo”); le visite ai nonni, tutti in fila a prenderci un bacio e un dolcino, e certe volte anche un bicchierino di qualche strano liquore al mandarino. E poi si torna tutti a casa, quasi all’ora di pranzo.
Spesso ci sono ospiti, zii e cugini, e il pranzo è davvero spropositato, ma non per la capacità gastrica di un bambino degli anni ’60, e dura molte ore con le tante portate, con le letterine e le poesie in piedi sulla sedia; e infine si portano le uova di pasqua, e da quel momento cominciano le delusioni, e rapidamente la Pasqua finisce, dopo tutti quegli infiniti, meticolosi preparativi, davanti a un pezzo di cioccolato profumatissimo, a rigirarsi tra le mani un porcellino di plastica rosa. E improvvisamente riappare in mente la cartella di scuola, i compiti non ancora finiti, il secondo trimestre da finire e il terzo ancora da cominciare, e l’estate ancora lontanissima. Con la magra consolazione del lunedì di pasquetta, ottimo giorno per uno che è ghiotto di uova sode, colorate o no, in gita o a casa, a fare un picnic in tinello, con gli avanzi.
(L.M. 04/19)

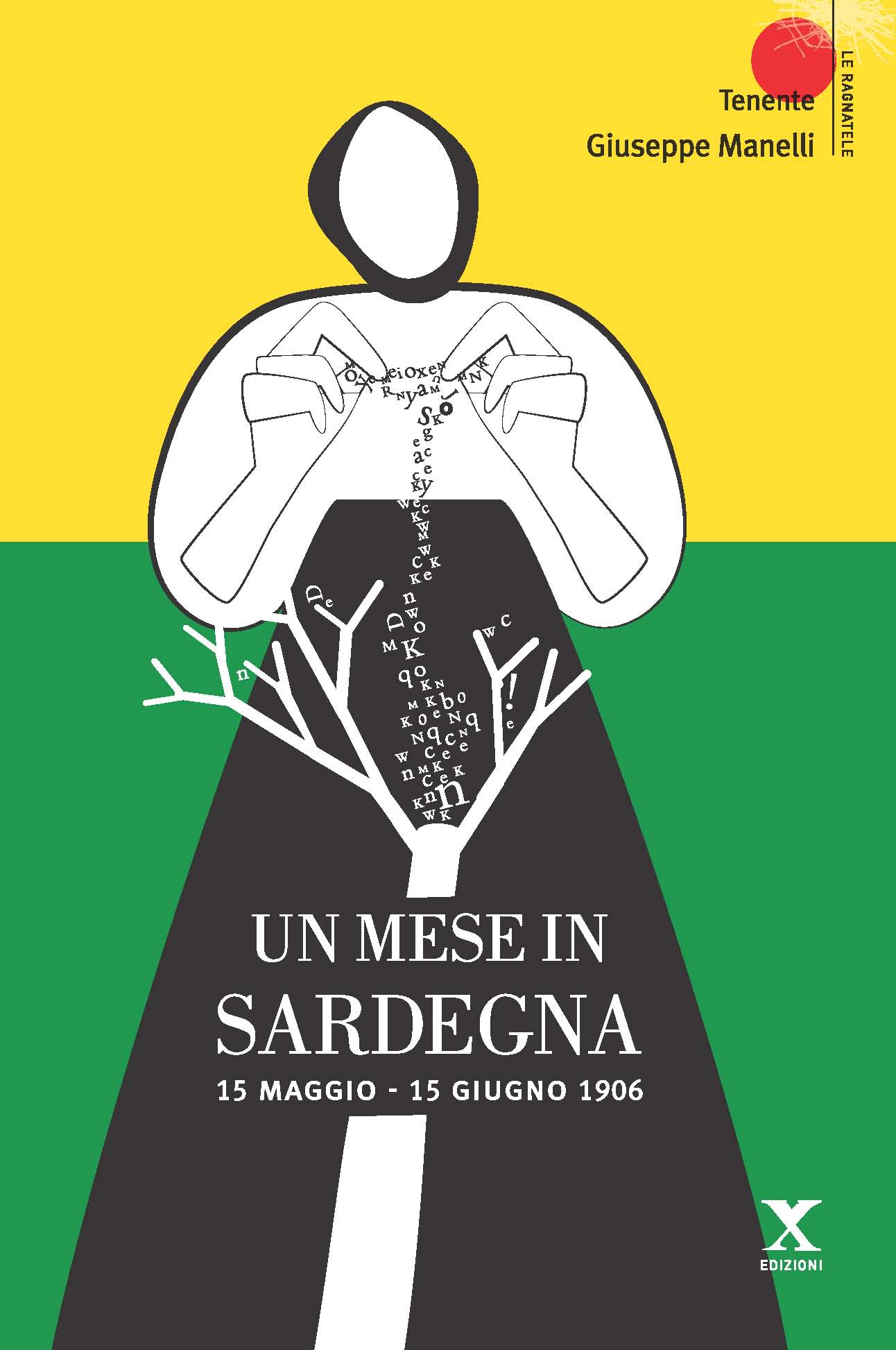
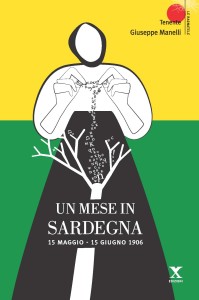 Resoconto di un breve soggiorno di un giovane tenente dei Bersaglieri di stanza a Bosa col suo plotone nella primavera del 1906. Questo libro fu pubblicato nel 1907 in un’unica edizione dalla Tipografia Conti e Gandolfi di Sanremo, e oggi costituisce una rarità.
Resoconto di un breve soggiorno di un giovane tenente dei Bersaglieri di stanza a Bosa col suo plotone nella primavera del 1906. Questo libro fu pubblicato nel 1907 in un’unica edizione dalla Tipografia Conti e Gandolfi di Sanremo, e oggi costituisce una rarità.